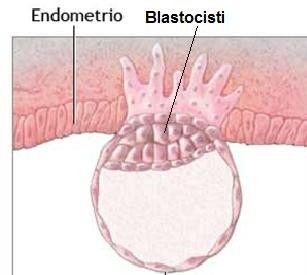Prendendo
le mosse dalla teoria psicoanalitica di Freud, ma contrapponendosi a
essa si sono sviluppate altre teorie delle dinamiche psicologiche del
profondo. Le maggiori scuole di pensiero sono quelle che fanno
riferimento alla psicologia analitica di Jung, alla psicologia
individuale di Adler, alla psicologia dell'Io di Erickson e alle teorie
di Melanie Klein.
•
Jung
Lo psichiatra svizzero
Carl Gustav Jung (1875-1961) è considerato il fondatore della
psicologia analitica.
Laureatosi in medicina nel 1900, entrò come assistente nel prestigioso
ospedale psichiatrico di Zurigo, e divenne allievo di J. Bleuler, che
aveva individuato nell'ampio genere della demenza i tratti specifici
della schizofrenia. Nel 1906 entrò in contatto con Freud e aderì
all'Associazione Psicoanalitica Internazionale. Nel 1913 ruppe con
Freud, dalle cui teorie psicoanalitiche si discostò nell'interpretazione
dell'inconscio e della libido. Anche per contrassegnare il proprio
rispetto, comunque mantenuto, nei confronti di Freud, Jung chiamò la
propria teoria “psicologia analitica”.
Fedele alle teorie di Bleuler, Jung ritiene che
l'inconscio precede la coscienza come una radice, piuttosto che seguirla come conseguenza di una rimozione.
Ciò significa che per comprendere lo psichico non bisogna partire dalla
costruzione dell'Io (come voleva Freud), ma dall'inconscio da cui l'Io
si genera.
Per Jung “inconscio” non è un luogo psichico come per Freud,
ma
un aggettivo che designa un insieme di “complessi” o gruppi di
rappresentazioni a tonalità affettiva molto elevata, che l'Io può
controllare o non controllare (in questo secondo caso siamo in
presenza della schizofrenia quale destrutturazione dei rapporti con la
realtà). All'inconscio si accede attraverso approcci metaforici, o
figure, quali l'
anima, che designa la parte femminile nel maschio; l'
animus, che designa la parte maschile nella femmina; l'“
ombra”, che è la parte negativa della personalità e che il soggetto tende a nascondere; la “
persona”, o maschera, che l'Io assume nelle sue relazioni sociali fino ad identificarvisi quando non è sicuro di sé.
Oltre
all'inconscio personale, in cui sedimentano le tracce delle esperienze
vissute, dimenticate o rimosse, Jung riconosce anche un
inconscio collettivo, in cui resta depositato il patrimonio psicologico dell'umanità.
Con questi termini non si deve però intendere un particolare contenuto
comune a tutti gli uomini, ma “forme a priori” dell'immaginazione,
disposizioni a fare esperienza in un modo piuttosto che in un altro.
Tali sono gli
archetipi della “grande madre”, o del
puer o del
senex, per i quali si decide il modo di fare esperienza in maniera materna, o infantile, o senile.
La dinamica psichica è concepita da Jung come relazione tra il Sé e l'Io. Con il termine
Sé Jung intese
l'unità complessiva della personalità:
“Il Sé non è soltanto il centro, ma anche l'intero perimetro che
abbraccia coscienza e inconscio, è il centro di questa totalità, così
come l'Io è il centro della mente cosciente”.
Del Sé Jung parlò in due accezioni: come momento iniziale della vita psichica e come
sua realizzazione o meta.
Come antecedente dell'Io, il Sé è l'espressione indifferenziata di
tutte le possibilità umane: una indifferenziazione mitologicamente
espressa dalla divinità rispetto alla quale un giorno l'uomo si era
emancipato inaugurando, con la ragione, identità e differenze: questa
emancipazione ha consentito all'uomo di uscire dalla notte
dell'indifferenziato, dove appunto abita la follia. Come figura
ulteriore rispetto all'ambito circoscritto della coscienza razionale, il
Sé rappresenta poi il riferimento per una nuova ricerca di senso volta
al recupero di motivi esistenziali rimossi per una adeguata costruzione
dell'Io.
La dinamica psichica in vista dell'autorealizzazione prevede una prima fase di adattamento alla realtà volta alla
costruzione dell'Io, e una seconda fase di
individuazione che si articola attraverso le due operazioni della
differenziazione e dell'integrazione,
da considerarsi a livello intrapsichico e interpsichico. Nel primo caso
“individuarsi” significa differenziare l'Io dalle istanze psichiche
inconsce, per passare successivamente a un'integrazione delle parti
rimosse che possono concorrere alla crescita dell'Io ormai consolidato.
Nel secondo caso individuarsi significa differenziarsi dall'adesione
acritica alle forme collettive d'esistenza, per passare poi
all'integrazione critica di forme e modelli culturali esistenti, da
sostituire a quelli che hanno presieduto per il passato alla crescita e
che ora si rivelano insufficienti.
Operatore del processo di individuazione per Jung è il
simbolo,
che, a differenza di quanto ritiene Freud, non è un segno che rinvia a
una cosa nota (campanile = fallo, caverna =
contenitore materno ecc.), ma è
ciò che rimanda a qualcosa di fondamentalmente sconosciuto e per il quale non c'è espressione razionale adeguata.
Jung
scorse nella produzione simbolica individuale e collettiva delle
eccedenze di senso rispetto all'insieme dei significati codificati. Da
queste eccedenze scaturiscono quelle trasformazioni individuali e
collettive in cui si esprime, a livello individuale, il senso di ogni
biografia e, a livello collettivo, quello di storia. In tal modo Jung
ampliò il concetto di psiche, lo emancipò dallo sfondo naturalistico in
cui Freud l'aveva contenuto,
identificando la psiche con le
pulsioni dell'uomo in quanto organismo biologico, e in definitiva lo
integrò con la nozione di storia: la storia come modificabilità della psiche in base alle trasformazioni epocali. Da questa esposizione si deduce che per Jung
non esistono contenuti simbolici se non per un inconscio che li instaura;
i simboli sono storici, perché non appena partoriscono il loro
significato cessano di essere simboli diventando segni; il simbolo non è
un significato, ma un'azione che mantiene in tensione gli opposti; nel
simbolo c'è un'eccedenza di senso verso cui si orienta il processo di
individuazione psichica.
Se l'
archetipo fa riferimento alla natura umana indicando ciò che è comune, la
tipologia psicologica
fa riferimento a ciò che diversifica individuo da individuo, per cui se
è ipotizzabile una visione oggettiva della psiche a livello
archetipico, questa visione si frantuma a livello tipologico, dove è di
volta in volta diverso il modo di essere uomo e di essere sé stesso. Ciò
spiega come per la psicologia analitica non si dia una dottrina
generale delle nevrosi, perché anche il modo di declinarsi della
malattia rispecchia l'individualità.
La psicologia elaborata da Jung viene definita dall'autore stesso con il termine di
Psicologia analitica. Staccandosi da una precedente adesione al pensiero psicoanalitico di Freud, nel 1912 con l'opera
Simboli della trasformazione
Jung prospettò una lettura dell'energia psichica o libido non più
limitata alle sole manifestazioni pulsionali come aveva ritenuto Freud,
ma estesa anche alle espressioni culturali con finalità creative.
Dopo Jung la psicologia analitica ha percorso due itinerari tipici che si discostano dallo junghismo classico. L'
itinerario archetipico, promosso da E. Neumann e J. Hillman,
che vuol sostituire al linguaggio concettuale in cui si esprime la
psicologia del profondo, il linguaggio immaginale proprio degli
archetipi mitologici, perché l'immagine è il modo specifico di narrarsi
della psiche, che non può essere distorto dalla sovrapposizione di un
linguaggio concettuale ad essa estraneo. Dall'altra parte
l'itinerario ermeneutico-epistemologico, promosso in Italia da Trevi,
il cui modello ermeneutico, conduce al dialogo dei punti di vista
prospettici e perciò stesso delle psicologie, tutte vere purché coerenti
con le loro premesse, e tutte relative perché storicamente,
psicologicamente ed esistenzialmente condizionate.
•
Adler
Medico e psicologo austriaco
A. Adler
fu all'inizio il membro più autorevole del piccolo gruppo che, fin dal
1902, si riuniva il mercoledì nella casa di Freud. Nel 1911 si distaccò
polemicamente da esso e fondò la
Società per la Psicologia Individuale.
Il termine individuale allude alla considerazione
dell'individuo come unità inscindibile sia in sé, sia nei rapporti con la società. Secondo la psicologia individuale la psiche è mossa dalla
volontà di potenza, concetto tratto da Nietzsche ma inteso in senso più benevolo: esprime il
bisogno di affermarsi ai fini della sopravvivenza
e ripara all'originario sentimento di inferiorità del bambino. Alla
volontà di potenza fa da contrappunto il sentimento sociale, che si
esprime nella capacità di solidarizzare emotivamente con gli altri e
dunque di cooperare nella società. Lo squilibrio tra queste due
componenti porta alla nevrosi.
Sul piano terapeutico scopo della psicologia individuale è di effettuare una
correzione
delle impostazioni erronee, derivanti da uno stile di vita inadeguato,
aiutando il paziente a vivere secondo una rinnovata progettualità. La psicologia individuale ha avuto seguito specie in Inghilterra e negli USA, anche per la sua
sensibilità al sociale, trovando inoltre convergenze con la psicoanalisi dei neofreudiani.
•
La psicologia dell'Io e Erikson
L'idea centrale della
psicologia dell'Io (cui aderì anche Anna Freud)
è che esiste una sfera dell'Io autonoma dai conflitti pulsionali:
la sfera dell'Io non deriva per differenziazione dall'Es, come voleva
Freud, né tanto meno dai processi di identificazione, bensì è innata.
Consiste in un'ampia serie di funzioni, quali il controllo della
motilità, il linguaggio, la memoria, l'intelligenza, l'esame della
realtà: sono
funzioni messe in azione non dalla libido, ma da forme di energia neutra, o neutralizzata;
all'insistenza sugli aspetti psichici delle funzioni dell'Io, fanno da
contrappunto i riferimenti neurofisiologici, al fine di
fondare biologicamente l'autonomia dell'Io.
È comunque in forza del suo carattere autonomo che
l'Io può opporsi alle pulsioni e regolare i rapporti con l'ambiente: il problema
dell'adattamento all'ambiente
diventa così centrale nella psicologia dell'Io, che aggiunge un punto
di vista adattivo e inoltre uno genetico (per l'attenzione prestata ai
processi evolutivi) ai tre punti considerati nella metapsicologia
freudiana (topico, dinamico ed economico). Lo scarso peso attribuito
invece alla dimensione fantasmatica inconscia fa sì che
le relazioni con il mondo esterno vengano lette in un'ottica per lo più realistica.
Con
Rapaport si ha inoltre il più importante tentativo di una
sistemazione epistemologica della psicoanalisi,
secondo i canoni dell'empirismo logico dominanti al tempo; vi prevale
una visione meccanicistica e obiettivistica della psiche.
La
psicologia dell'Io ha trovato fortuna negli Stai Uniti anche perché si
incontrava con due questioni sentite nella cultura locale: il rapporto
con l'ambiente e con la società; la scientificità della psicoanalisi e
la sua integrazione nella psicologia accademica.
Uno studioso riconducibile per certi versi alla Psicologia dell'Io è
E. Erikson,
psicoanalista statunitense di origine tedesca. Formatosi con Anna Freud
a Vienna (ma è da sottolineare che prima aveva insegnato attività
artistiche ai bambini), emigrò negli Stati Uniti nel 1933, dove insegnò
in varie università. Si occupò prevalentemente di
psicoanalisi dell'età evolutiva, studiando il bambino nel contesto sociologico e antropologico. Nella concezione di Erickson
l'acquisizione dell'identità individuale e di quella sociale sono complementari:
da una parte è sottolineata la funzione di sintesi e di integrazione
svolta dall'Io nel corso dello sviluppo, dall'altra è dimostrata (con
una famosa ricerca in cui veniva confrontata l'educazione nelle tribù
Sioux, cacciatori, con quella nelle tribù Yurok, pescatori)
l'interazione tra la formazione dell'Io e la struttura della società.
•
Melanie Klein
Psicoanalista
inglese, di origine austriaca, si accostò alla psicoanalisi nel 1914
attraverso Ferenczi, allievo di Freud; ma riconobbe come maestro K.
Abraham a Berlino, dove si trasferì nel 1921. La morte precoce di
Abraham la indusse a stabilirsi definitivamente a Londra nel 1926. Qui
fu dapprima accolta con favore, ma dagli anni Quaranta incontrò la
vivace opposizione del gruppo ortodosso, capeggiato da Glover e da Anna
Freud.
La Klein aveva iniziato la sua pratica come analista di
bambini, nella cura dei quali traspose direttamente i principi
freudiani.
Utilizzando il gioco, lo interpretava al bambino in
termini simbolici al pari del sogno negli adulti, vedendovi
l'espressione di pulsioni, di conflitti, di angosce inconsce. Ne trasse le prime tesi originali: il
complesso di Edipo compare già nei primi anni di vita;
il bambino mostra un universo fantasmatico assai ricco, popolato di oggetti dal carattere di quasi-persone, ora crudeli, ora dotate di mirabili qualità.
Il rigido
dualismo pulsionale (pulsioni lipidiche e pulsioni aggressive o di morte), la visione della
mente come mondo interno
(cioè un contenitore di oggetti di volta in volta proiettati
all'esterno o introiettati), nonché l'allargamento della cura ad adulti
psicotici favorirono l'elaborazione delle nozioni di
posizione paranoide-schizoide e
posizione depressiva. Le due posizioni compaiono rispettivamente nel primo e nel secondo semestre di vita del bambino. La posizione
paranoide-schizoide
è qualificata dalla percezione del seno materno da parte del bambino
ora come oggetto buono, ora come oggetto cattivo (in quanto il
seno è investito di pulsioni sia lipidiche, sia aggressive), dalla
presenza di angoscia persecutoria (per una sorta di timore di vendetta
al seguito degli immaginari attacchi al seno), o, al contrario, di
straordinarie idealizzazioni.
La posizione depressiva suppone dal canto suo la
riunificazione del seno in un unico oggetto (sentito come buono):
il soggetto vive conseguentemente se stesso come cattivo, donde
l'angoscia depressiva. Nelle ultime opere la Klein accentuò il
peso dei sentimenti, postulando nel bambino un'originaria invidia e una necessità di farvi fronte con atteggiamenti riparatori.
Altri orientamenti
In
una seconda fase, accanto alle grandi scuole analitiche, si sono
sviluppate altri indirizzi interpretativi e terapeutici, dalla
psicologia umanistica di Maslow e Rogers alle psicoterapie
comportamentiste e cognitiviste e alle teorie dei tratti.
•
Maslow e Rogers: le teorie umanistiche
Abraham Maslow, di cui
abbiamo già analizzato
la teoria dei bisogni e delle
motivazioni, fondò nel 1962 la Società Americana di
Psicologia Umanistica.
Maslow sottolineò
l'importanza dei valori nello sviluppo della personalità,
criticando l'impostazione del comportamentismo e della psicoanalisi,
ritenuta troppo riduttiva e meccanicistica. Il suo approccio si
caratterizzò anche per la tendenza a
studiare persone definite come sane,
dalla cui osservazione e analisi Maslow derivò le caratteristiche delle
persone autorealizzate, che rispecchiano da molti punti di vista la
personalità comune, da cui traggono il meglio essendo a proprio agio con
sé stesse e capaci di affrontare i propri limiti. La teoria
dell'autorealizzazione di Maslow fu tuttavia criticata come
eccessivamente indefinita e imprecisa (spesso, notano i detrattori dello
studioso statunitense, anche la gerarchia dei bisogni da lui
prospettata non viene rispettata in maniera rigorosa).
Carl Rogers,
altro psicologo statunitense, di formazione psicopedagogica, nel 1930
divenne direttore della società per la prevenzione della crudeltà ai
bambini a Rochester (NY). Professore di psicologia in varie università,
fondò centri di consulenza, avviando in essi il metodo della
terapia centrata sul cliente. Ne è premessa l'idea che
la fonte principale del comportamento sia il bisogno di autorealizzazione,
il quale porta ad uno sviluppo spontaneo e lineare (a meno di
scontrarsi con l'ambiente). Pertanto, criticando sia le terapie
direttive come quella comportamentista (vedi sotto
Le teorie comportamentali e cognitiviste), sia la psicoanalisi, sostenne che
l'approccio al paziente debba essere fondato sull'empatia,
cioè un rapporto a tu per tu, benevolo comprensivo, che valorizza la
spinta autonoma alla crescita. La peculiarità del rapporto
terapeuta-cliente determina tempi e modalità di ciascun trattamento. Le
tesi di Rogers, accostabili alla psicologia umanistica di Maslow, hanno
avuto successo anche in Europa.
•
Le teorie comportamentali e cognitiviste
Secondo i
comportamentisti la personalità dipende dall'insieme
dei comportamenti appresi sulla base del
condizionamento operante, nel quale, come si è visto, ha un'importanza significativa il ruolo del rinforzo. La
psicoterapia ispirata al comportamentismo pensa di
togliere il sintomo senza coinvolgere l'insieme della personalità:
essendo il sintomo un errore di apprendimento, occorre decondizionare
il soggetto, avvicinandolo gradualmente all'elemento patogeno e
mostrandogli che non sussistono i pericoli che teme.
Secondo i
cognitivisti le
differenti personalità deriverebbero dai diversi processi di pensiero e
dalle rappresentazioni mentali degli altri e della realtà che ci
circonda. Il loro intervento si può avvicinare a quello
prospettato dai comportamentisti: presupponendo che il comportamento si
basa su cognizioni e schemi. Mira alla riorganizzazione delle cognizioni
errate del paziente su sé stesso e sugli altri.
•
Le teorie dei tratti
Alcune delle prime teorie che hanno preso direttamente in considerazione la
personalità (quelle di Allport, Cattel e Eysenk) l'hanno intesa come
caratterizzata da un insieme di tratti innati o disposizioni stabili applicabili a tutti gli individui, sia pure con differenze per quanto riguarda il numero e il tipo di tratti esistenti.
Gordon Allport, psicologo americano, intese dunque la personalità come l'insieme di diversi
tratti (
cardinali, che influenzano ogni azione compiuta dalla persona;
centrali, che pur essendo forti non possono vantare la coerenza dei cardinali,
e secondari,
che si esprime in ambiti più limitati dei centrali) che, sebbene comuni
in molte persone, possono indurre ogni individuo a comportarsi in
maniera diversa. Secondo Allport
non possono esistere due persone identiche: la sua teoria ha pertanto lo scopo di
salvaguardare l'unicità e irripetibilità dell'individuo.
Nel comportamento di un individuo è pertanto importante analizzare sia
la combinazione dei tratti, sia le differenze situazionali.
Anche
Raimond Cattel contribuì allo sviluppo della teoria dei tratti della personalità, identificando ed elaborando un elenco di
16 fattori che potevano essere utilizzati per descrivere tutti gli individui e predirne il comportamento, fornendo una rappresentazione adeguata della loro personalità. Egli distinse i
tratti superficiali (caratteristiche comuni che è possibile trovare in più persone diverse) dai
tratti originari (fattori fondamentali della personalità).
Hans Eysenk
sostenne insieme a Allport e Cattel l'esistenza nella personalità di
diversi tratti comuni relativamente stabili e misurabili; in particolare
egli distinse la personalità in
tre fattori principali (
introversione-estroversione, nevroticismo e psicoticismo) che isolò utilizzando la metodologia statistica dell'analisi
fattoriale.
I disturbi del comportamento
La
sofferenza mentale e i disturbi del comportamento sono comunemente
suddivisi i due grandi gruppi a seconda che il soggetto conservi o
perda il senso della realtà: nel primo caso abbiamo la famiglia delle
nevrosi, nel secondo il gruppo delle psicosi.
•
Nevrosi
In psicopatologia, con il termine
nevrosi ci si riferisce a una
famiglia di disturbi mentali di origine psichica in cui il soggetto, diversamente dalla psicosi, conserva il senso della realtà.
Il
significato di nevrosi è assai variato nel corso del tempo e in
funzione delle diverse correnti di psichiatria e psicopatologia. Il
termine venne introdotto dallo scozzese Cullen nel 1777, per indicare
sia le malattie mentali, sia quelle attribuibili al sistema nervoso. La
scuola di
J.M Charcot (seconda metà dell'Ottocento)
distingueva le malattie nervose organiche da quelle funzionali,
dovute cioè a difetti del funzionamento del sistema nervoso senza
compromissione anatomica: sono le nevrosi nel senso odierno.
La
psicopatologia contemporanea è concorde sulla definizione negativa delle nevrosi, come un
insieme di disturbi del comportamento di cui non si trova patogenesi organica.
Freud insistendo sull'origine puramente psichica dell'isteria, che
riteneva causata da rappresentazioni mentali che il soggetto non
riusciva ad accettare, fondò la psicoanalisi su una concezione psicogena
della nevrosi.
La nevrosi nelle
classificazioni psicopatologiche è abitualmente
distinta sia dalla psicosi, in cui il soggetto, sopraffatto dalle dinamiche inconsce, dà luogo a deliri e allucinazioni;
sia dalla perversione e dalla psicopatia, in cui non vi è rimozione della pulsione;
sia dal disturbo psicosomatico, che presenta lesioni organiche obiettive.
La psicoanalisi
nello sterminato repertorio dei sintomi nevrotici individua alcuni
quadri di nevrosi, basati non tanto sulla classificazione dei sintomi
quanto sulle dinamiche psichiche atte a spiegare detti quadri. La
nevrosi appare così
l'esito di un conflitto psichico,
radicato nella storia infantile del soggetto, e il sintomo nevrotico è
il compromesso tra un desiderio inaccettabile e la difesa da esso. Il
sintomo ha dunque un carattere simbolico: rinvia alla rappresentazione
di un desiderio come al suo significato.
Comportamentismo e riflessologia spiegano
la nevrosi come la risposta inadeguata allo stress, ovvero come errore di apprendimento a seguito di apprendimenti sfavorevoli.
Si distingue tra isteria e nevrosi ossessiva.
L'isteria è caratterizzata dalla conversione del conflitto psichico in sintomi somatici (paralisi funzionali, anestesie, afasie, cecità e tanti altri), senza compromissione anatomica.
La nevrosi ossessiva presenta sintomi meramente psichici,
quali coazioni a ripetere azioni insensate, pensieri ossessivi
(blasfemi, di colpa, o altro), a cui il soggetto non può sottrarsi. La
nevrosi fobica, cioè la paura immotivata di oggetti, animali, luoghi, è
da taluni accostata alla nevrosi ossessiva (nevrosi fobico-ossessiva),
da altri, come Freud, all'isteria (isteria d'angoscia).
Freud accomunò le nevrosi appena elencate con il nome di nevrosi di transfert:
in tutte permane la relazione con oggetti (reali o di fantasia),
relazione che inoltre il soggetto può indirizzare ad altre persone,
come accade nel transfert verso il terapeuta.
Contrappose le nevrosi di transfert alle nevrosi narcisistiche o psicosi (per le quali il soggetto, chiuso nel suo mondo perde la capacità di relazionarsi con gli oggetti esterni)
e alle nevrosi attuali
. Quest'ultima famiglia di nevrosi, la cui consistenza è oggi
discussa, non ha origine da un conflitto infantile, ma attuale (per
esempio, la nevrosi d'angoscia deriverebbe da un mancato deflusso delle
eccitazioni sessuali). Condivisa invece anche al di fuori della
psicoanalisi è la nozione di
nevrosi traumatica,
che scoppia a seguito di eventi sconvolgenti. Ma il fatto che non tutti
gli individui reagiscano con la nevrosi a un trauma o a forti emozioni,
fa pensare che siano comunque decisive le componenti nevrotiche
pregresse.
•
Psicosi
Il termine
psicosi fa invece riferimento a
disturbi psichici gravi di origine organica.
Proprio la diversa origine differenzia le psicosi dalle nevrosi: le
nevrosi non hanno cause organiche (somatiche) ma solo cause psichiche;
mentre le psicosi hanno nella loro insorgenza fondazioni organiche che,
per alcune, sono conosciute e dimostrabili e, per altre, sono soltanto
ipotizzabili. Le nevrosi si possono definire anche come esperienze
psicopatologiche contrassegnate da deviazioni quantitative dalla norma
(intesa in senso statistico), e le
psicosi quali esperienze psicopatologiche caratterizzate da deviazioni qualitative dalla norma .
Nel contesto delle psicosi si devono preliminarmente distinguere quelle
correlabili a cause organiche dimostrabili.
Sono, queste, le psicosi chiamate da E. Kraepelin psicosi organiche: le
più comuni sono conseguenti a lesioni traumatiche dell'encefalo, a sue
lesioni degenerative o vascolari, a sue forme infettive e, in
particolare, all'infezione luetica che conduceva, quando non era ancora
adeguatamente curata, all'insorgenza della cosiddetta paralisi
progressiva, malattia oggi praticamente scomparsa, ma della quale morì,
per esempio, Nietzsche. Le psicosi organiche, indipendentemente dalle
loro cause, presentano una
sintomatologia psichica comune che si differenzia per ciascuna solamente sulla base dell'evoluzione. Le psicosi organiche acute sono caratterizzate essenzialmente da
disturbi della coscienza,
e cioè dalla compromissione più o meno profonda ed estesa, fino alla
perdita totale, delle capacità di orientarsi nello spazio e nel tempo.
Le psicosi organiche acute sono patologie che hanno un duplice
possibile andamento: possono
risolversi anche completamente, o possono sconfinare nelle psicosi organiche croniche . Queste ultime non presentano disturbi della coscienza ma si hanno
disturbi dell'intelligenza e della personalità, ad andamento strisciante e progredente, fino alla loro profonda destrutturazione nelle forme cosiddette demenziali.
Antitetiche e contrapposte alle psicosi organiche sono quelle convenzionalmente chiamate
endogene .
 Origini e cause sono ancora oggi oscure e indimostrate
Origini e cause sono ancora oggi oscure e indimostrate,
anche se l'indirizzo scientifico prevalente è quello inteso a
considerarle di natura organica, benché non si possa escludere
l'influenza di fattori integrativi di natura ambientale e
interpersonale. Delle psicosi endogene fanno parte sostanzialmente
due sole grandi
forme cliniche che sono state genialmente
individuate e
descritte da Kraepelin : la psicosi maniaco-depressiva e la dementia praecox (schizofrenia). In realtà il termine di
psicosi maniaco-depressiva,
che vuole indicare la presenza e la successione in una stessa persona
di episodi maniacali e di episodi depressivi, viene oggi sostituito da
una duplice denominazione: quella di depressione bipolare e quella di
depressione monopolare. La prima intende caratterizzare le forme
cliniche in cui, come nella definizione originaria di Kraepelin,
episodi maniacali ed episodi depressivi si alternano nel corso della
vita di una persona, ad intervalli diversi di caso in caso; la seconda
intende invece indicare le forme cliniche, molto più frequenti, in cui
si alternano nel corso della vita solo episodi di natura depressiva. Se
il termine di psicosi maniaco-depressiva continua a sopravvivere in
alcuni circoli psichiatrici di forte ascendenza kraepeliana, non si
parla più di
dementia praecox, ma la stessa sintomatologia e la
stessa formula clinica vengono definite come schizofrenia. Fu Bleuler a
introdurre in psichiatria il termine di
schizofrenia, infinitamente più adatto a cogliere gli aspetti costitutivi della malattia (con schizofrenia, dal greco
schízein
, “scindere, dividere”
prhén,
“mente” si esprime etimologicamente il concetto di scissione, di
dissociazione, di lacerazione della vita psichica), malattia nella quale
la demenza è solo apparente.
Delle due
psicosi endogene , le
depressioni bipolari e le depressioni monopolari sono contrassegnate dalla presenza di un sintomo fondamentale, costituito dal
disturbo della vita affettiva, della vita emozionale,
al quale sono aggregati altri sintomi più o meno importanti e
significativi clinicamente. Il disturbo dell'affettività è
contrassegnato nel corso degli episodi maniacali, che si osservano solo
nelle depressioni bipolari, da una condizione di gaiezza (euforia)
patologica che mantiene solo alcune analogie tematiche con la normale
allegria.
L'euforia patologica nella fase maniacale non è
infatti motivata, cioè non è determinata da eventi significativi che
abbiano a giustificarla, ma è del tutto immotivata. Essa inoltre si
accompagna ad una concitazione psicomotoria talora molto accentuata,
che entra in conflitto flagrante con le norme e le consuetudini sociali
ed istituzionali. Il disturbo dell'affettività che si constata nella
depressione psicotica (nella depressione che si alterna alla
eccitazione maniacale e in quella che si ripete da sola nel corso di
una vita) è contrassegnato dalla presenza di uno stato d'animo
(immotivato) di tristezza e di malinconia più o meno intenso e più o
meno doloroso. A questa tristezza patologica, a questa depressione
clinica, si accompagna una condizione di apatia e disgusto della vita
che, in alcune forme cliniche, sconfinano nel rifiuto di vivere e nella
ricerca disperata della morte volontaria, del suicidio. Nel corso di
una depressione di questa natura non si riesce più ad entrare in
contatto con il mondo degli altri e ci si rinchiude sempre più
profondamente nei confini della propria interiorità, del proprio io.
Se curati bene, sia gli episodi maniacali sia quelli depressivi regrediscono e si risolvono .
La sintomatologia e l'evoluzione della
schizofrenia
sono invece molto più oscure
ed enigmatiche. Insorge abitualmente in età giovanile e la sua
evoluzione nel tempo può avvenire in forma acuta o in forma cronica,
ciascuna di queste forme ha una diversa sensibilità all'azione
terapeutica dei farmaci.
La sintomatologia della schizofrenia
è multiforme e camaleontica, benché la sua struttura portante si
riconosca in una scissione e in una dislocazione della personalità e
delle diverse funzioni che compongono la vita psichica nel suo insieme.
Sono
comunque sintomi ricorrenti di questa psicosi: un ripiegamento sul
mondo interiore e un rifiuto di contatti esterni ( autismo
), repentini passaggi dall'attaccamento al disprezzo per
il medesimo oggetto (
ambivalenza), comportamenti bizzarri. Nel
linguaggio si osserva una seria destrutturazione della sintassi,
mentre singole parole – talora costruite artificiosamente e ripetute
ossessivamente – concentrano in sé un gran numero di significati; le
parole inoltre sono prese per cose, ignorando i sensi metaforici
(“perdere la testa” per qualcosa equivale, per esempio, a essere senza
testa, decapitato). Il
corpo infine è spesso sentito come cosa estranea : il soggetto può infliggersi terribili trattamenti, senza provare dolore.
Accanto al
fattore ereditario e a quello costituzionale , sui quali specie in passato si insisteva, sono state studiate in tempi recenti le
concomitanti biochimiche nel
cervello di schizofrenici (iperattività dei neuroni sensibili alla
dopamina): esse però non tolgono il concorso di importanti fattori
ambientali e psichici. Questi ultimi nell'ottica psicodinamica,
risalgono alla prima infanzia: a modalità assai disturbate nel rapporto
con la madre, specie nel passaggio dalla fase simbiotica, alla
separazione e alla relazione con gli oggetti. La
Klein
sottolineò la presenza di assetti schizoidi già nel primo anno di vita, caratterizzati
dalla scissione dell'Io e dell'oggetto con cui il bambino si rapporta e
dall'affiorare di angoscia persecutoria. Infine la
scuola sistemica , o di Palo Alto, ha
insistito sul ruolo schizofrenogeno esercitato da famiglie
in cui le modalità di
comunicazione tra i membri sono perverse, paradossali, caratterizzate
dal
doppio legame. Secondo G.
Bateson e la scuola di Palo Alto, questa è una modalità comunicativa in
cui l'emittente invia al destinatario segnali contraddittori o
contrastanti con altri messaggi non verbali, ponendolo in una
situazione paradossale. Il carattere patogeno deriva, oltre che dalla
contraddittorietà dei messaggi, dalla natura intensa del legame tra i
partner e dall'impossibilità del destinatario di parlare della
comunicazione al fine di risolvere l'incongruenza. Il conflitto si
riversa sul paziente designato, cioè l'anello debole della catena
familiare.
In sintesi